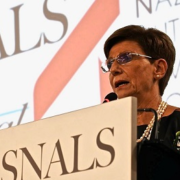“La scuola tra criticità di sistema e disagi professionali del personale”. Le proposte dello Snals.
Intervento del Prof. Vito Masciale, Consigliere Nazionale SNALS nonché Segretario Provinciale di Bari, nell’ambito della Tavola Rotonda, “La scuola tra criticità di sistema e disagi professionali del personale”, tenutasi a Treviso il 16 maggio 2019.
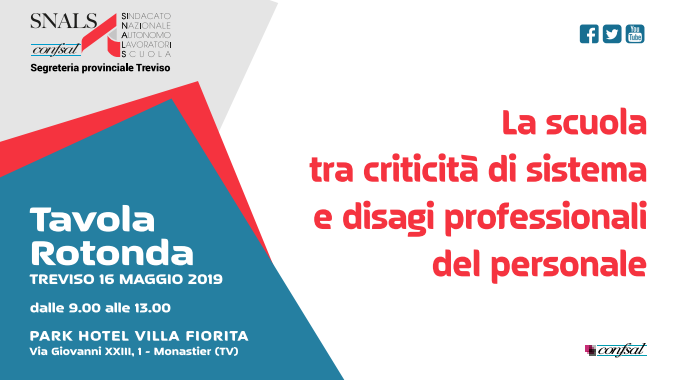
Questa riflessione è sorta negli ultimi mesi, nel momento di maggior tensione fra governo e sindacati, quando lo sciopero generale sembrava ormai ineluttabile. Esso è stato poi revocato, ma il confronto continua.
A proposito degli stipendi il Governo si è impegnato a garantire nel triennio il recupero graduale del potere d’acquisto delle retribuzioni del personale scolastico e, contestualmente, ad avviare un percorso per un graduale avvicinamento alla media dei livelli salariali di altri Paesi europei.
Prendendo a confronto la posizione stipendiale media di carriera (15 anni), il gap percentuale tra la retribuzione di un docente italiano rispetto a quello medio dei colleghi europei oscilla tra il 18,2% dei docenti dell’infanzia e il 29,4% dei docenti della primaria, mentre per i professori di scuola media è del 24,3% e per quelli delle superiori del 26,7%.
Si è parlato, anche, di “chiara e condivisa considerazione del ruolo assegnato alla scuola per garantire identità e unità culturale del Paese, anche attraverso l’unitarietà dello stato giuridico del personale, il valore nazionale dei contratti, un sistema nazionale di reclutamento del personale e le regole per il governo delle scuole autonome”.
Passo ora al tema del nostro incontro.
Per far fronte alla situazione attuale occorrerebbe un piano strategico per il rilancio della scuola pensato su un orizzonte di almeno 10 anni e condiviso dalle principali forze politiche e sociali. Principale obiettivo il successo formativo di tutti gli studenti, da ottenere attraverso una drastica personalizzazione degli itinerari formativi individuali.
Bisogna riportare la scuola al centro del dibattito pubblico, come un ambito su cui investire e non solo effettuare tagli di spese improduttive. È importante aver chiaro che, come già accade nei principali Paesi Ocse, gli investimenti nel campo dell’educazione, formazione, ricerca e innovazione rappresentano la leva strategica per uscire dalla crisi e rilanciare lo sviluppo.
Nello scenario attuale, serve una vision della scuola come comunità educante coesa ed eticamente responsabile, dove il dirigente non è semplicemente un manager, ma un leader educativo capace di attivare processi innovativi, governare con il consenso e incrementare le motivazioni del personale e degli stessi studenti, la condizione necessaria per poter migliorare i risultati della singola scuola e del sistema educativo più in generale.
In questa prospettiva, occorre ridefinire un “Patto per lo sviluppo educativo” che coinvolga tutti gli attori e accompagnare il processo di riforma con un consistente programma di formazione rivolto a dirigenti scolastici, docenti, studenti e genitori, in modo tale da “creare le condizioni” culturali e professionali per l’effettiva implementazione di quanto indicato nelle norme legislative.
Inoltre, per rilanciare una nuova mission della scuola in Italia, si dovrebbero recuperare due questioni strategiche: il grave fenomeno della dispersione scolastica e l’elaborazione di una seria politica di orientamento scolastico, formativo e al lavoro permanente, che sia in grado di coinvolgere tutti gli attori interessati (personale della scuola, imprese, istituzioni) in modo consapevole e responsabile far dialogare il mondo della scuola e quello del lavoro e delle professioni.
Sono numerosi i problemi che la scuola italiana deve affrontare. Per quanto riguarda i ragazzi e la preparazione al lavoro, va sottolineato come il 20% dei giovani (il doppio che in Europa) non ha il diploma della scuola secondaria superiore, non studia, non lavora, non cerca lavoro), mentre percentuale di quelli disoccupati è del 38% (ancora una volta il doppio che in Europa).
Anche dal punto di vista della preparazione alla vita da cittadini le percentuali sono allarmanti: l’Italia ha il 14% di abbandoni precoci, mentre il 50% dei giovani è attore o vittima di bullismo, il 66% non ha trattato a scuola temi di educazione civica, il 75% non conosce la Costituzione.
Quanto alle “competenze funzionali” degli adulti (16-65 anni) secondo l’indagine OCSE–PIAAC il livello di “analfabetismo funzionale” in Italia è del 30% della popolazione (15 % nella UE), mentre il livello di “competenze adeguate o elevate” è solo del 30% (65% nella UE).
Ci sono peraltro “due Italie”, una vicina al Nord Europa e l’altra lontanissima.
Per rimediare a questa situazione drammatica è necessario puntare sul successo formativo di tutti gli studenti (recuperando il 20% che si perde). Ciò si può ottenere solo differenziando l’offerta formativa attraverso una radicale personalizzazione.
Per compensare gli squilibri di educabilità derivanti dal contesto socioeconomico la proposta può essere la scolarizzazione precoce e a tempo pieno: tutti a scuola obbligatoriamente dai 3 ai 14 anni, fino alla fine della scuola media, con un’attività di orientamento sin da questo ordine di scuola molto più efficace.
Per gli studenti della scuola secondaria superiore va valutata la possibilità di dedicare nel pomeriggio 30 ore per attività formative liberamente scelte dagli studenti (sport, volontariato, educazione delle emozioni), ma valutabili. Serve una forte integrazione tra i diversi momenti di attività curricolari, senza la quale il “tempo lungo” non produce effetti positivi.
Riformare la struttura e la finalità della scuola in modo da garantire il successo formativo di tutti gli studenti, senza scarti: il 20% di fallimenti scolastici costituisce una vera e propria bomba sociale e politica. Se questo problema non sarà risolto ci saranno rischi non solo per la coesione sociale ma anche per la stessa democrazia.
Per questo serve un impegno pubblico in materia di scuola, la nostra Costituzione affianca al diritto universale all’istruzione (e al corrispondente dovere della Repubblica di “rimuovere gli ostacoli” che lo impediscono) il diritto delle famiglie a scegliere il modello educativo per i propri figli. Ma è possibile oggi che la scuola, si preoccupi solo dei “capaci e meritevoli”, come dice la Costituzione? La vera rivoluzione, oggi, è quella della scuola generalizzata e del successo per tutti.
Ma ciascuno a suo modo, “perché non siamo tutti uguali” per tempi e stili di apprendimento.
Fermo restando l’impegno individuale nello studio, i percorsi vanno resi flessibili partendo dalle attitudini e potenzialità dei singoli studenti
Quanto ai docenti, determinante è la qualità degli insegnanti: formati meglio e pagati meglio.
La scuola italiana non ha il tempo per poter aspettare una nuova generazione di docenti formati, in futuro, in appositi corsi di laurea finalizzati specificamente all’insegnamento. La formazione serve ora e per tutti (quelli che sono già in cattedra o sono in attesa di una supplenza).
La necessità di un “cambiamento radicale”, individua in un consistente aumento degli stipendi degli insegnanti la misura SIMBOLO di un nuovo e diverso atteggiamento del Paese nei confronti della scuola nazionale e di chi vi opera.
Tuttora la scuola è vista più come centro di spesa e opportunità di occupazione per il personale che come investimento, più che riformare occorre trasformare.
Il “come” si insegna conta infatti spesso più del “che cosa” si insegna.
Occorre puntare su un maggiore protagonismo dei docenti, partire dalle persone, e quindi costruire percorsi di apprendimento personalizzati dando ad esse fiducia e stimolando il dialogo, affinché si eviti la formazione, favorita dalla diffusione dei social, gruppi chiusi nei quali non c’è dialogo ma condivisione unilaterale di convinzioni di parte.
Ma ci deve stare a cuore il benessere dei nostri docenti, perché i soldi aiutano a stare meglio, danno lustro sociale in una società dove tutto si misura in denaro ma da soli non fanno la felicità: bisogna creare un ambiente di lavoro sicuro e sereno.
LA CARRIERA DEGLI INSEGNANTI
Il settore scuola è l’unico settore del servizio pubblico statale senza possibilità di carriera.
Servono figure intermedie per far funzionare un meccanismo complesso come la scuola adeguatamente, personale preparato con funzioni specifiche, strutturate e retribuite in maniera non estemporanea, il vice dirigente, il responsabile della didattica, il responsabile dell’innovazione.
L’accesso alla carriera di Dirigente dovrebbe essere riservato solo a chi ha ricoperto nella scuola ruoli intermedi di gestione e responsabilità.
LA SCUOLA DI QUALITA’
Serve, infine, la valutazione esterna delle scuole da parte di un ente di cui sia garantita l’assoluta indipendenza, quanto all’adesione delle scuole alle innovazioni, è opportuno che essa sia progressiva e volontaria, ma sempre esplicitamente supportata a livello istituzionale.
PATTO EDUCATIVO SCUOLA FAMIGLIA
Fondamentale, comunque, è la ricostruzione del patto educativo tra società, scuola e famiglie.
La materia andrebbe regolamentata perché, se lasciata per intero all’autonomia delle singole scuole potrebbe dar luogo a un aumento, anziché alla riduzione, delle disuguaglianze. Non basta la firma delle famiglie su un documento che le scuole secondarie superiori fino a ieri (dall’anno prossimo sembra ogni ordine di scuola) fanno firmare alle famiglie al momento dell’iscrizione e che poi nella realtà viene disatteso.
Le dimensioni della crisi della nostra scuola, la crisi dell’alleanza educativa tra scuola e famiglia, come mostrano le sempre più numerose aggressioni ai docenti, dipendono anche dall’arretratezza del modello organizzativo, che impedisce di sfruttare razionalmente le enormi potenzialità del nostro sistema educativo attraverso una rinnovata partecipazione degli studenti e dei genitori alla vita della scuola, attraverso organismi ad hoc, su una serie di questioni cruciali: elaborazione del Piano triennale dell’Offerta formativa; innovazione tecnologica, didattica e metodologica; valutazione dei risultati; coinvolgimento degli attori sociali presenti sul territorio.
Gli organi collegiali sono sterili ed inutili perché obsoleti: a quando la loro riforma?
LE RISORSE
Sul versante della spesa e del rilancio degli investimenti per l’istruzione, è necessario recuperare risorse e rilanciare gli investimenti. In Danimarca si spende circa l’8% del PIL, in Italia solo il 4%. Rapportato al PIL italiano vorrebbe dire incrementare la spesa per l’istruzione di circa 65 miliardi di euro l’anno. Con queste risorse gli insegnanti sarebbero pagati meglio, le scuole sarebbero interamente digitalizzate e piene di laboratori interattivi
– Il decremento demografico e la conseguente diminuzione della popolazione scolastica, ridurrebbe la spesa Miur di due miliardi di euro in pochi anni. Occorre evitare che tali risorse vengano sottratte alla scuola: reinvestendole si potrebbe rafforzare il tempo pieno/lungo e realizzare una adeguata formazione iniziale e continua dei docenti, in previsione del gigantesco ricambio dei prossimi anni.
Un esempio di cattiva gestione è costituito dai sette miliardi di euro che vengono spesi tra Miur ed Enti locali per il sostegno senza che il servizio funzioni in modo efficace: molte scuole sono inagibili, i docenti cambiano spessissimo.
LA PROPOSTA DI LEGGE SULL’EDUCAZIONE CIVICA
Qualche cenno merita, infine, la proposta di legge sull’Educazione Civica, approvata dalla Camera il 3 maggio e che ora passa all’esame del Senato. Essa ha esteso alla scuola primaria il ‘Patto di corresponsabilità educativa’ già in vigore nella scuola secondaria. Questo non esclude che possano essere decise sanzioni nei confronti degli alunni, ma solo alla fine di un percorso di confronto e condivisione con le famiglie. Ma che cosa fare quando la famiglia è assente e non vuole assumere alcuna (cor)responsabilità? La punizione (penale) del genitore in aggiunta a quella (scolastica) dello studente. Misure che si collocano entrambe, in modo diverso, al di fuori di ogni logica di condivisione e corresponsabilità educativa. E che non si pongono il problema del recupero sociale di entrambi. È come rassegnarsi all’idea che per una minoranza di ragazzi (e di genitori) non ci sia altro destino che l’emarginazione o la galera. Noi non ci rassegniamo, ma occorre essere consapevoli che per vincere la battaglia dell’inclusione servono una lucida determinazione e robuste dosi di coraggio e di pazienza.
Il voto pressoché unanime (3 astenuti) con il quale la Camera ha approvato la proposta di legge che ridefinisce l’educazione civica nei curricoli della scuola italiana ha ricevuto l’attenzione dei media più per ciò che ha tolto dall’ordinamento che per ciò che ha aggiunto: un impressionante elenco di contenuti e obiettivi dei quali la materia-non materia – o “insegnamento trasversale”, come lo definisce la legge – dovrà farsi carico.
Il tutto in 33 ore annuali non aggiuntive e “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Così sono tutti soddisfatti: i partiti perché ciascuno di essi si può riconoscere in qualcuno dei contenuti di questa legge omnibus e anche il ministro dell’economia, perché la legge non comporta costi aggiuntivi. Ma l’unanimità, raggiunta in Parlamento, un suo costo ce l’ha: quello di rendere questo insegnamento nello stesso tempo straripante e impalpabile. Un ulteriore problema per le scuole e gli insegnanti che se ne dovranno occupare. Ma ci sono risorse per formare i docenti sulle tematiche? C’è il rischio di una eccessiva indeterminatezza della nozione stessa di Educazione civica, derivante dallo sterminato numero di obiettivi formativi elencati dalla legge, che per la sempre più ampia gamma degli obiettivi ad essa affidati non poteva che essere configurata come un “insegnamento trasversale affidato ad un docente e coordinatore e ai docenti della classe nella loro collegialità”. Ma se è bene che la legge richiami la pluralità degli obiettivi, “ancora più importante” è porre l’accento su quello che va oggi considerato come l’obiettivo prioritario, l’educazione alla cittadinanza digitale, perché “l’avvento di internet, delle reti sociali, dei nuovi mezzi di informazione e comunicazione, ha determinato cambiamenti dirompenti sia sul terreno dei diritti e delle libertà sia sulle forme di partecipazione alla vita democratica. In sintesi, sui contenuti essenziali della nostra Carta costituzionale”.
Serve un piano straordinario di formazione dei docenti” che accompagni una adeguata formazione digitale degli alunni anche in funzione dell’uso corretto di internet.
“Dobbiamo agire in fretta”, perché la rivoluzione di Internet influenza le nostre realtà. A noi spetta il compito di coniugare tutto ciò con i valori propri della nostra Costituzione, che rimandano alla partecipazione, alla sussidiarietà e alla democrazia; ma non abbiamo più molto tempo, è questo il tempo. Ora bisogna ripartire: “Chi vuole davvero una cosa troverà una strada, gli altri una scusa”.
Il Consigliere Nazionale SNALS
Prof. Vito Masciale